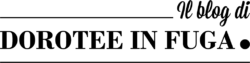Dopo più di vent’anni di lavoro in casa di riposo, da sei mesi lavoro a Cremona, in una medicina di gruppo con altri 6 colleghi.
A inizio anno si comincia a sentir parlare di un nuovo virus che ha causato diversi morti in Cina. Ascolto al telegiornale le notizie con interesse professionale, ma senza un reale coinvolgimento emotivo: in passato cii sono state altre di epidemie simili a questa, nessuna ci ha riguardato da vicino.
Ma le notizie sono sempre più allarmanti: si profila una vera e propria epidemia. La città di Wuhan, una metropoli, non un paesino sperduto nella campagna, viene messa in quarantena. Mi commuovono le immagini delle persone chiuse in casa che cantano alla finestra. Una sera guardo con stupore la costruzione in tempi record di un intero ospedale: questo fatto, più di ogni altro, mi fa comprendere la reale portata del problema. L’inquietudine comincia a farsi strada nei miei pensieri: sono un medico di base, se l’epidemia dovesse arrivare in Italia sarò in prima linea. Sembra ancora un’evenienza impossibile.
Iniziano ad arrivare alcuni comunicati dall’ATS: alcune stringate indicazioni, che raccomandano di tenere sotto controllo eventuali pazienti provenienti dalla Cina con sintomatologia simil-influenzale.
Ascolto un’intervista ad Angelo Pan, primario infettivologo a Cremona, che mostra i provvedimenti intrapresi dall’ospedale per far fronte ad un eventuale arrivo del virus: sostanzialmente l’aumento di alcuni posti letto nel suo reparto. Sembra tutto sotto controllo. Eppure…
Il 21 febbraio arriva la prima diagnosi: un paziente di Codogno, a pochi chilometri da Cremona, ha contratto il coronavirus.
Il giorno dopo, un sabato, sono di turno in ambulatorio. Mi rendo conto di non avere nemmeno una mascherina a disposizione. Passo in farmacia prima di entrare in servizio: il farmacista mi ride in faccia e mi dice che sono esaurite. Vado comunque al lavoro: la mia collega Donatella, con grande generosità, mi raggiunge con alcune mascherine chirurgiche. Mi racconta che hanno già identificato un secondo caso nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Cremona, che i colleghi sono tutti in quarantena.
Dopo circa mezz’ora arriva la prima paziente: una ragazza di 17 anni con febbre elevata da più di 5 giorni, mal di gola e tosse. Nella sua classe c’è un ragazzo di Codogno… Cerco di mettermi in contatto con il numero verde, sempre occupato. Chiamo allora il 112: in genere rispondono dopo qualche squillo… Questa volta resto in attesa per quasi 30 minuti senza ottenere risposta. Chiamo quindi direttamente il pronto soccorso dell’ospedale, avvisandoli che arriverà la mia paziente, con una sintomatologia sospetta. Avviso la madre della ragazza di farsi riconoscere subito, senza restare in sala d’attesa, per evitare il rischio di contagiare altre persone; fornisco a madre e figlia due delle poche, preziose mascherine in mio possesso; raccomando di farmi sapere l’esito del tampone appena possibile.
Resto chiusa in casa per tutto il weekend in isolamento completo, per paura di essermi contagiata e trasmettere a mia volta la malattia alle persone care. La notizia della negatività del tampone arriva la domenica pomeriggio, dopo una notte quasi insonne. Tiro un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Non immagino minimamente ciò che succederà nei giorni successivi, e cioè che l’esperienza vissuta quel sabato mattina si ripeterà di continuo, amplificata in modo angosciante.
La settimana successiva inizia all’insegna della spasmodica ricerca dei DPI: insieme ai medici del gruppo chiediamo un aiuto all’ATS che dopo qualche giorno fornisce a tutti i MMG una prima partita di mascherine, disinfettanti, camici monouso, guanti. Cerchiamo di integrare acquistando ciò che si trova in rete, a prezzi elevatissimi. Riorganizziamo lo studio: la sala d’attesa viene spostata in un vano che può essere ventilato facilmente; le visite vengono svolte solo su appuntamento e per urgenze; si inviano le ricette via mail o sms, cercando di evitare assembramenti.
Mercoledì sera ricevo una telefonata che mi gela il sangue: Giancarlo, il collega prossimo alla pensione con cui divido lo studio (nonché la scrivania, il mouse e la tastiera del pc …) ha la febbre a 39°. Mi rassicura: “non ho nessun sintomo, chissà…”
Cominciano a fioccare le telefonate dei pazienti. Stessa sintomatologia per tutti: febbre alta, persistente, tosse secca. Non ho armi per combattere: raccomando di prendere la tachipirina, di idratarsi, di mantenere l’isolamento. Domando se ci sono difficoltà respiratorie. Mi creo un file Excel con nome, telefono, qualche notizia clinica, e inizio un monitoraggio telefonico quotidiano.
I primi colleghi, specie medici di base, cominciano a “cadere in battaglia”. L’ATS raccomanda di non esporsi, ma i Pronto Soccorso sono pieni, i numeri verdi sovraccarichi…. I pazienti dopo giorni di febbre elevata vanno visitati! Non ci tengo a fare l’eroe, ho una paura terribile di ammalarmi, ma vado a visitarli. Come me, i miei colleghi dello studio. In tre si ammalano di polmonite, uno di loro è tutt’oggi in rianimazione.
Il primo paziente che vado a visitare a casa è un avvocato settantenne, che ho conosciuto circa un mese prima in ambulatorio. Personalità brillante, in ottima salute, affetto solo da ipertensione. Ha la febbre già da 5 giorni, non riferisce nessun altro sintomo. Per prima cosa, misuro la saturazione: 85%. Impossibile! Il paziente non sembra in insufficienza respiratoria: mi parla tranquillamente, forse una lievissima polipnea, ma nulla di più. Ausculto il torace, qualche crepitio. Controllo che il saturimetro non sia rotto, provandolo su di me: saturo 98%. Chiamo l’ambulanza che arriva da Crema dopo un’ora. Il paziente viene ricoverato all’ospedale di Mantova, perché l’ospedale di Cremona, dopo solo una settimana dalla diagnosi del paziente 1 di Codogno, è già saturo. Ricevo dalla moglie qualche notizia su WhatsApp, nei giorni seguenti: ossigenoterapia, Cpap, rianimazione… In quattro giorni il paziente muore. Erano questi gli anziani polipatologici destinati a soccombere al virus? Sono una geriatra, abituata ai pazienti delle case di riposo, grandi anziani con grave polipatologia. Questo paziente aveva davanti ancora tanti anni da vivere in salute. Non dite più che si tratta di influenza!
Qualche giorno dopo mi chiama la nipote di una mia paziente 84enne che vive sola: mi riferisce che ha trovato la zia, solitamente lucidissima e completamente autonoma, un po’ confusa e con difficoltà a camminare. Chiedo espressamente se ha la febbre o sintomi similinfluenzali, mi risponde di no. La mia esperienza di geriatra mi suggerisce di non abbassare la guardia. Prima di entrare indosso al volo una mascherina e i guanti. La paziente scotta, le misuro la febbre: ha 38,5°. La saturazione è 85%. Chiamo l’ambulanza: il giorno dopo avrò la conferma che si tratta di polmonite covid 19. La paziente morirà in pochi giorni.
Sono stata a contatto ravvicinato con lei, le ho tenuto il termometro sotto l’ascella…
Quando arrivo a casa metto tutti i vestiti in lavatrice, faccio doccia, capelli, persino i gargarismi…. Ormai ho capito che non c’è da scherzare: la malattia è molto più diffusa di quello che si pensa, non ci sono categorie a rischio. La signora non è mai stata a Codogno, non si è mai mossa dal suo quartiere. Chissà da quanto tempo a Cremona il virus ha viaggiato sottotraccia…
Da quel momento, inizio a considerare tutti i pazienti potenziali Covid.
La mia bella borsa di cuoio viene sostituita da uno zainetto in tela lavabile. Al suo interno poche cose: il saturimetro, il fonendoscopio, il ricettario, una penna, l’alcol per disinfettare tutto. Identifico nella mia automobile dei “percorsi” ben precisi, per non creare commistione tra l’abbigliamento da “civile” e la “tenuta da guerra”. Prima di entrare in casa di un malato faccio arieggiare la stanza, faccio indossare la mascherina a tutti i presenti, limito la visita al minimo indispensabile, poi esco e procedo ad attenta svestizione, disinfettando tutto.
La settimana successiva è un incubo. Il lunedì 9 marzo, in particolare, è una giornata che non scorderò mai. Una raffica di telefonate: ne ho contate 120. Alle 12 ho la batteria del cellulare scarica.
Il pomeriggio è dedicato alle visite domiciliari. Ricovero 5 persone in insufficienza respiratoria. L’età: 38, 40, 57, 60, 80 anni.
La prima paziente è una signora di 60 anni. Ha la saturazione a 89%. Chiamo il 118 che dopo una ventina di minuti mi dice che manderà l’ambulanza. Esco senza aspettarla perché ho tante altre visite. Dopo circa mezz’ora mi chiama la volontaria dell’ambulanza, dicendomi che ha ricevuto ordine dalla centrale di riportare la paziente in casa, anche se l’aveva già caricata sul mezzo. Furiosa, telefono in centrale, investendo di improperi la persona che si è permessa di mettere in discussione da una scrivania una mia valutazione fatta sul campo, rischiando la pelle. L’operatrice rimanda l’ambulanza e la paziente viene ricoverata. Dopo due giorni viene intubata. Adesso è a casa ed è guarita.
Il ragazzo di 38 anni ha appena perso il padre per covid 19. Il giorno dopo ricovero anche il fratello. Entrambi vengono intubati, trasferiti uno a Trieste, l’altro a Varese. La telefonata con la madre, una signora che ha qualche anno più di me, è straziante.
La sera arrivo a casa con la sensazione di non farcela più. La situazione sembra senza speranza. La notte non chiudo occhio, in preda a continue crisi di panico. No, decisamente non sono un eroe e sperimento tutta la mia umanità, i miei limiti, la paura di morire, di perdere le persone care…
Passo il poco tempo libero cercando febbrilmente su internet notizie sulla malattia. C’è un gruppo di medici su Facebook con cui posso scambiare opinioni, esperienze, stati d’animo.
Cominciano ad arrivare notizie confortanti sulle prime terapie efficaci. Chissà: forse qualcosa posso fare anche a domicilio. Si parla del Plaquenil, dell’azitromicina, dell’eparina…
L’ospedale di Cremona organizza una videolezione rivolta proprio a noi medici di base, in cui Angelo Pan, primario Infettivologo e Gianfranco Bosio, primario pneumologo, danno indicazioni sulle terapie: si cerca una sinergia con il territorio, per trattare il paziente precocemente. Illuminante la lezione del Prof Viale circolata su Internet, che spiega la necessità di intervenire già a domicilio con terapie volte a ridurre l’infiammazione e i rischi tromboembolici. Non c’è ancora una netta evidence su queste terapie, ma avere qualche arma a disposizione fa sentire meno la frustrazione e l’impotenza. Mi fa sentire di nuovo utile e riaccende la speranza. Il lockdown fa il resto: con il passare delle settimane di distanziamento sociale, i casi si riducono progressivamente. Sono sempre meno coloro che devono ricorrere all’ospedale, ancor meno in rianimazione. L’ATS mette in campo le USCA, delle équipe con medici ed infermieri dotati di adeguati DPI che possiamo contattare ed inviare al domicilio dei pazienti febbrili per alleggerire il nostro lavoro e tutelarci. La tensione si allenta, ricomincio a dormire la notte.
Nell’ultimo mese i riflettori si accendono sugli anziani morti nelle RSA. I numeri sono effettivamente terribili. Tuttavia credo di essere stata testimone di situazioni altrettanto angoscianti sul territorio.
Un martedì mattina ricovero un signore di 80 anni che vive con la moglie. La coppia non ha figli, né parenti prossimi. Due giorni dopo la moglie non ha ancora avuto notizie. Nessuno la chiama, forse non ha lasciato nessun recapito telefonico ai volontari dell’ambulanza, lei è anziana e non sa destreggiarsi tra centralini e numeri verdi vari. Provo io a mettermi in contatto con i colleghi dell’ospedale, ma sono giorni “caldissimi”, i medici sono carichi di lavoro e non riesco a parlare con nessuno. Interesso del caso l’Ufficio Relazioni Pubbliche dell’ospedale. Il giorno dopo il medico del reparto telefona alla moglie del paziente e la informa sulle condizioni cliniche, non solo: va al letto del malato, si accorge che ha il cellulare scarico, lo aiuta a caricarlo e a chiamare la moglie! Un gesto di tenera umanità che mi ha commosso.
Una signora affetta da demenza vive con il marito, suo unico caregiver. Non hanno figli. Il marito muore di covid, e lei resta sola al proprio domicilio, per circa un mese, prima che una nipote si accorga della gravità delle sue condizioni. La donna è dimagrita 20 chili, non ha assistenza, ha atteggiamento aggressivo e minaccia di buttarsi dal balcone. Viene chiamata l’ambulanza per un ricovero coatto.
Un giorno mi chiama l’agenzia di pompe funebri: mi chiede se posso compilare un certificato di morte per un signore anziano che è stato trovato morto nella sua stanza, non si sa da quanto tempo. Il paziente viveva con il figlio, malato di covid, che, febbricitante nella stanza accanto, non si è accorto di niente. La salma rimane in casa per quattro giorni, non c’è un posto dove metterla, non c’è possibilità di anticipare il funerale, i morti sono troppi.
Una domenica mi chiama il figlio di un novantenne affetto da demenza; l’anziano vive con due badanti che si alternano giorno e notte. Ha certamente una polmonite da coronavirus con una saturazione ancora accettabile, vista l’età e la comorbilità. Decidiamo insieme al figlio di tenerlo a casa, vista anche la situazione negli ospedali. Il problema compare dopo qualche giorno, perché entrambe le badanti si ammalano. Devo per forza ricoverare il paziente, perché altrimenti rimarrebbe senza assistenza. Il paziente morirà dopo qualche settimana, solo, in ospedale.
Non riesco nemmeno più a contare, infine, le telefonate che ricevo da persone anziane, rimaste per due mesi in balia della solitudine, della paura, della sensazione di abbandono, che mi cercano solo per un saluto o per sentirsi rassicurati dal suono di una voce amica.
E questo mi porta a un’ultima riflessione: se è vero che molti ospiti delle RSA si sono gravemente ammalati di covid, spesso fino a morirne, in quelle strutture almeno hanno trovato terapie, ossigeno, sedazione, assistenza di base e, soprattutto, qualcuno accanto a stringergli la mano fino all’ultimo istante.
Luisa Guglielmi